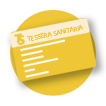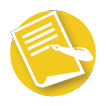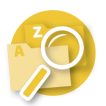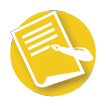Franco Rotelli e la Parma di Mario Tommasini. Che cos’è la psichiatria - di Pietro Pellegrini - febbraio 2024
A Mantova il 17 febbraio 2024 si è tenuto un incontro in ricordo della figura di Franco Rotelli in concomitanza con la mostra fotografica sul manicomio di Leros, presso la Casa del Rigoletto. L'incontro, dal titolo Il percorso di formazione di Franco Rotelli (Casalmaggiore, Parma, Mario Tommasini, Franco Basaglia), con Pietro Pellegrini e Luigi Benevelli, è un ricordo della figura del medico psichiatra Franco Rotelli (1942-2023) a un anno dalla sua morte.
L'intervento integrale di Pietro Pellegrini, sub commissario sanitario e direttore del Dipartimento Assistenziale Integrato Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DAI-SMDP) dell'Ausl di Parma, in dialogo con lo psichiatra e storico Luigi Benevelli ed il pubblico.
Introduzione
Ringrazio Luigi Benevelli e Giovanni Rossi per l’invito. Mi fa molto piacere essere qui in quanto ritengo sia stata un’ottima iniziativa dedicare la mostra sul manicomio di Leros di Antonella Pizzamiglio al ricordo del Prof. Franco Rotelli ad un anno dalla morte.
Credo sia importante la memoria, specie in questo periodo nel quale le esclusioni e le discriminazioni sembrano trovare giustificazione nella pubblica opinione. La questione detentiva, i suicidi, i fatti di Reggio Emilia e quelli accaduti durante il Covid a Modena, Santa Maria Capua Vetere appaiono assai inquietanti. Lo stesso per le condizioni dei Centri per i Migranti e i tanti naufragi con oltre 2600 morti in mare. Migranti che lavorano spesso in nero nelle campagne o nei cantieri dove muoiono, insieme ad operai italiani, come ieri a Firenze.
Dopo la pandemia siamo passati alla sindemia che si sta cronicizzando e oltre alle conseguenze sanitarie e sociali, si intreccia con guerre in Europa, in Palestina e in tante altre parti del mondo, crisi economiche ed ambientali. Sono in crisi le democrazie e avanzano i rischi di nuove svolte autoritarie. L’umano va verso il post-umano e l’antropocene rischia di sfociare in una catastrofe (climatica e nucleare) mettendo a repentaglio il futuro della vita sul pianeta. Passo dal dovere di ricordare al tema di oggi.
Franco Rotelli e la Parma di Mario Tommasini
E’ un argomento complesso, in larga parte ancora da scrivere. Infatti, molto resta da ricercare in quanto vi sono frammenti di filmati, articoli, interventi che visti nell’insieme possono dare a Rotelli il pieno riconoscimento per il ruolo avuto non solo come collaboratore di Basaglia per la chiusura dei manicomi e poi nell’attuazione della legge 180 ma soprattutto per aver saputo individuare una via per il futuro non solo della salute mentale ma dell’intero sistema del welfare pubblico universale.
Mi riferisco a “L’Istituzione inventata” (2015) e a “La città che cura” (Gallio 2018). “La radicalità evidente della riforma psichiatrica si vuole estendere ad un’idea concreta di un’altra sanità, di una ‘politica per la salute’, di una politica del bene pubblico e di un pensiero sulle istituzioni che noi stessi siamo che possono ad ogni momento aprirsi o rinchiudersi (e rinchiudere)” (2015). Se questo è un pericolo l’altra grande questione è costituita dalla crescita della solitudine, dell’isolamento, dell’abbandono, del rifiuto dell’accoglienza dell’altra persona fino al disconoscimento dei diritti, della dignità e persino della comune umanità. Punto di approdo comune dell’istituzionalizzazione e dell’abbandono dell’altro. Questo genera anche inconsapevolmente una perdita e una ferita in ciascuno di noi nella misura in cui l’identità è costituita dallo sguardo dell’altro. Una condizione che porta all’indifferenza, a non indignarci nemmeno quando siamo di fronte ad immagini strazianti di morte e distruzione.
Per preparare queste note ho fatto alcune ricerche e letture e vi esporrò alcuni punti senza alcuna pretesa di essere esaustivo ma con l’idea di guardare al futuro e pensare che altri apporti (scritti, filmati, fotografie, testimonianze ed al. di cui anche oggi ho avuto prova) possano completarlo.
Franco Rotelli
Mi sono potuto avvalere di un’intervista inedita a Franco Rotelli effettuata nel 2021 da Roberta Giampietri, psicologa del Ruolo Terapeutico di Parma, in preparazione di un evento che si sarebbe dovuto tenere a Parma nel 2022. Interrogato su come sia arrivato ad essere psichiatra Rotelli risponde:
“Forse come ci arrivano altri: faccio medicina, dopo un po’ mi stufo di vedere dei morti, dei cadaveri e degli oggetti cadaverici. Mi immaginavo la medicina come una cosa in cui i soggetti fossero molto più importanti, così vado a curiosare dalle parti della psichiatria per vedere se lì succedono cose più vitali dal punto di vista dei rapporti, delle persone, più interessanti a livello relazionale. Così incontro un professore universitario singolare nell’Astanteria Psichiatrica di Parma: Carlo De Risio. All’epoca non esisteva ancora la clinica psichiatrica, stiamo parlando degli anni 60, esisteva solo la Clinica delle Malattie Nervose Mentali, diretta da un notevole barone: il professor Visintini. La psichiatria aveva a disposizione uno scantinato dentro la clinica diretto da De Risio, persona molto seria, intelligente e attenta, in grado di coniugare la pratica dell’elettroshock con l’incoraggiamento agli allievi a leggere Sartre e Luckacs e a seguire il filone che cominciava in psichiatria ad avere un suo ruolo ed un sua dignità. Era un marxista, stranamente mescolante l’atteggiamento medico molto legato alla biologia con studi e curiosità verso la filosofia e l’esistenzialismo. Poi col servizio miliare lascio la clinica. Al ritorno ho bisogno di guadagnare e inizio a lavorare a Castiglione delle Stiviere: lì mi pagano subito 300.000 lire al mese che oggi equivarrebbero a 3|4-000 euro… e lì comincio la mia pratica reale nella psichiatria.”
Poi, nel 1970 Rotelli lavora con Basaglia a Colorno con assessore Mario Tommasini. Una testimonianza molto importante di quel periodo la dà Antonio Slavich del quale nel 2019 è stato pubblicato postumo un suo scritto “A Parma aspettando Basaglia”. Infatti, Slavich e Scittar iniziarono a lavorare a Colorno nel 1969 prima dell’arrivo di Basaglia. Secondo Slavich di quel periodo “nessuno ne parla o ne scrive più; neppure gli stessi protagonisti”. Parma, rappresenta “l’anello mancante” nell’evoluzione dell’esperienza “goriziana” in quella “triestina”. (Pag. 361) Poi fa un cenno a “I futuri triestini, che saranno falange compatta a Trieste, a Parma lasciavano intravedere le loro nature umane. Rotelli sempre duro, perentorio e propositivo, allegro non si mostrava mai.” (Slavich pag. 384)
L’esperienza di Rotelli a Colorno è da lui rievocata nel film “l’Ordine della follia” (2009) e nel numero di Aut Aut del 2009 a cura di Giovanna Gallio. Nel testo, scritto nel 2002, Rotelli commenta i verbali delle riunioni di Colorno e acutamente annota: “aveva allora anche senso parlare di vestiti, di mense, di come far passare le notti insonni, di come cercare uno scopo comune minimamente sensato alla vita dentro un istituto insensato, di come affrontare il tema dell’uscire fuori, di come stare dentro, il tema del potere gli uni sugli altri, dei pregiudizi”. “Ma oggi tutto questo non ha più senso: era l’affrontamento di una certa comunità chiusa. Oggi il tema della psichiatria è altro, è la malattia.”
E continua: “sorgerà pian piano forse solo ad alcuni un dubbio, come un tarlo: e se quello fosse ancora il luogo tematico del praticamente vero e quest’altro, della malattia, il luogo ideologico del travisamento, lo specchietto per le allodole dove si è di nuovo smarrito il filo delle questioni?
“Da che sorge il ragionevole dubbio per il quale la nostra stessa vita si scioglie pure nella questione del lavoro, dello stare dentro e del venire fuori, della quotidiana dialettica dei poteri, del senso/non senso, singolare/plurale dell’esistere ogni giorno, della quotidiana economia delle cose del discrimine, del pregiudizio, della notte insonne: forse allora si parla di noi. Ora”. (pag.6,7)
Questo pone il tema dell’essere concreto della democrazia, “come inverarla, come agire ogni giorno la lezione, questa sì terapeutica, di come costruire modi della democrazia affrontandone, dentro un luogo specifico che la negava con particolare evidenza, le evidenti aporie: cercando di tradurle, in contraddizioni, aperte, esplicite e quindi produttive di vita, di cambiamenti, di emancipazione.”
Prestare attenzione alle persone, ai bisogni, ai progetti di vita, ai diritti e alla libertà viene prima di ogni terapia. Elementi comuni a tutti gli esseri umani. In questa co-esistenza occorre saper accogliere e abitare le inevitabili contraddizioni, decostruirle come insegna Deridda, all’interno del metodo democratico, di una dialettica partecipata e inclusiva per cogliere insieme ai bisogni e risorse delle persone, il valore delle diversità, delle minoranze, del dissenso e del conflitto in un sistema di diritti riconosciuti e reciprocamente assicurati, a partire dalla dignità della persona e dell’uguaglianza, di beni e destini comuni.
Quindi attenzione alla complessità della persona, del suo contesto e all’interazione dei diversi fattori superando, decostruendoli, pregiudizi e stigmi. Ad esempio di fronte alla pericolosità Basaglia si esprime in modo chiaro e spiazzante: “la pericolosità non risiede nella specificità della diagnosi, dipende dalla mancanza di risposte ai bisogni delle persone”.
Che cos’è la psichiatria?
Allora che cos’è la psichiatria diviene il punto interrogativo. Riferendosi alle pratiche di Colorno, Rotelli scrive (pag. 7): “si ragiona se quella fosse psichiatria critica, non psichiatria, critica della psichiatria, antispsichiatria o nuova psichiatria. Non si riuscì mai bene a stabilirlo. Sorge il ragionevole dubbio per il quale l’unica psichiatria accettabile non possa che essere altro dalla psichiatria. Cos’altro?”
“E cosa dovrebbe essere la terapia se non scuola di emancipazione? E’ come farlo il problema. Ma un problema vero, non risolto, è altro dagli innumerevoli falsi problemi su cui si disloca confermandosi come ideologia, come ideologia, cioè come imbroglio: la psichiatria rifondata sul fittizio oggetto inerte della malattia, Feticcio”.
Da questo consegue la necessità di una psichiatria che deve ripensare il proprio oggetto e al tempo stesso se stessa, la sua epistemologia, gli ambiti istituzionali e sociali delle sue pratiche. Un tema complesso quello della definizione dell’oggetto, dei costrutti psicopatologici e dei metodi per studiarli e trattarli. Bisogni, risorse, malattia, istituzioni, relazioni e contesto sociale sono i riferimenti di una psichiatria che può basarsi su alcuni presupposti.
Uno è che lo psichiatra è sempre parte del campo della(e) relazione(i) ed è contemporaneamente strumento della diagnosi e della terapia. Questa implica la partecipazione della persona sofferente in un continuo processo di soggettivazione reciproca che può mettere tra parentesi la malattia, per occuparsi di diritti ed emancipazione della persona. Un destino che lega indissolubilmente paziente e psichiatra. E in termini più generali, ci ricorda che ogni persona è legata all’altra.
Se il paziente è rappresentato come irresponsabile e pericoloso a se e agli altri, lo psichiatra specularmente è chiamato sulla base della posizione di garanzia a controllarlo, custodirlo? La richiesta che lo psichiatra sia un “garante-custode” del malato di mente, non solo non è compatibile con la legge, l’organizzazione e le competenze professionale ma rischia, al contempo, di far regredire tutto il processo di riforma aprendo una fase di nuova, strisciante re-istituzionalizzazione.
Oggi dovremmo leggere il malattia mediante la complessità, la dialettica tra molteplici fattori, biologici, psicologici, sociali, ambientali e culturali, in un quadro di diritti e doveri paritari (compresa l’imputabilità) e mai diminuiti dalla malattia in una comunità accogliente e solidale che fa della salute e del benessere un bene comune.
Un approccio olistico va sempre realizzato e costruito insieme e su misura utilizzando nelle pratiche le migliori e più avanzate conoscenze, rispettando e promuovendo i diritti, con equilibrio e la saggezza a partire dalla quotidianità (Giovanni Rossi, 2018) e facendo delle incertezze, dei dubbi e delle contraddizioni elementi di crescita della persona e della comunità. Una dialettica fra ciò che sta tra parentesi (la malattia, la persona) e ciò che sta fuori.
In quegli anni, rispetto a Parma e all’Emilia Romagna, Rotelli è assai critico. Egli coglie già nell’esperienza di Basaglia a Colorno indizi di quella che sarà “la futura via emiliana alla psichiatria, fatta di pronte soluzioni, utili a negare, nascondere, rendere invisibili i problemi piuttosto che a farne terreno di cambiamento, questione aperta, interrogazione su un più ampio sistema, le sue inerzie, i suoi giochi di potere di potere? Per qualcuno ogni problema deve avere la sua rapida soluzione, per Basaglia ogni soluzione era sempre la parte più preoccupante del problema” (pag. 7). “Preoccupare la soluzione, far capire a tutti che, nel mentre era dovuta, era contemporaneamente foriera di nuove più difficili insidie” e di nuove contraddizioni.”
Soluzioni come risposte adialettiche, lontane dai bisogni reali, che si fanno istituzione la quale si “autoregola, si ricostituisce come famelica creatura, si ciba dei propri bisogni di riproduzione e non della risposta a quelli di coloro per i quali avrebbe dovuto essere creata.” (pag.8)
L’ideologia dell’ordine istituzionale e del sapere medico non toccano la realtà dei rapporti “rifiutandosi di sporcarsi le mani alla ricerca di una soluzione/non-soluzione (…) silenziare e ignorare con la giusta giustificazione politica e o scientifica. Trasformare mai. Trent’anni dopo, la psichiatria emiliana cresce su quell’albero secco. Con Tommasini che continuerà ad agitarsi, protestando inutilmente” (pag. 8).
Mario Tommasini
Qualche anno dopo nell’intervista per il film “L’ordine della follia” Rotelli parlerà di Tommasini come di una persona totalmente eccentrica rispetto a quanto è successo. Un operaio che non aveva studiato è stato capace di interrogare tutti, di fare un discorso universale per il quale tutti, ma proprio tutti, possono fare qualcosa per la salute mentale dell’altro. “Nessuno escluso. Nessuno: né da una parte né dall’altra. Sapeva che ognuno ha bisogno dell’altro. Che l’alternativa è la barbarie” (Rotelli, 2017 pag.16). E questo a mio avviso il suo grande insegnamento nel momento in cui sottrae il disturbo mentale alla sola esclusiva competenza della psichiatria e fa della salute mentale una componente essenziale della salute, come dirà molti anni dopo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Dal “chi non ha non è” il proverbio calabrese citato da Basaglia nell’intervista “I Giardini di Abele” di Sergio Zavoli “al chi non è non ha” del disconoscimento fino al “al chi è ha” della soggettivazione e della reciprocità. Se si tratta diversamente il malato, cambia il suo modo di esprimersi e di comportarsi. E’ l’altra “scoperta” dell’umanità sommersa che nel quotidiano mina il sistema di regole rigide e stereotipate del manicomio e liberata porta alla libertà. Non a caso “Libera la libertà” sarà il nome del movimento fondato da Mario Tommasini nel 1998.
Rotelli si chiede come sia potuto esistere un personaggio come Tommasini che ha cercato costantemente di coinvolgere la politica, la società civile e tutta la città. Lo ha fatto sostenuto da quella che Rotelli definisce una “furia liberatoria” con dimissioni dall’OP di degenti senza preparazione invadendo anche le competenze psichiatriche… e creando un clima culturale favorevole mediante libri, film (Matti da slegare, Bellocchio, foto e mostre (Berengo Gardin e Carla Cerati), spettacoli teatrali (tra cui Dario Fo).
Tommasini è stato un intellettuale moderno del “sapere pratico”, capace di utilizzare la multimedialità che “ha combattuto per allargare il confine della democrazia laddove non c’era mai stata”. “Carceri manicomi, istituti per minori istituti per anziani, le grandi aree dell’handicap, della disabilità, furono il terreno della sua azione” (Rotelli, 2017). Un intellettuale in grado di generare conflitto, polemiche, dibattito, partecipazione, di promuovere utopie concrete.
Tommasini si confronta con tutte le istituzioni totali con obiettivi diversi: di chiuderle come i manicomi, i brefotrofi e gli orfanatrofi, gli istituti per minori; di farne venire meno la necessità, come il carcere, fornendo alternative, casa e lavoro (fonderà la Coop Sirio); di indicare che è possibile costruire soluzioni alternative alle case di riposo mediante alloggi protetti come a Tiedoli (PR). In ogni ambito ci prova, avanza ragioni, cerca di convincere, di vincere insieme favorendo il dialogo e l’incontro. Vuol dimostrare che si può fare!
La dinamica antistituzionale sa bene che il percorso è lungo e che vi è sempre il rischio che le istituzioni totali, repressive e adialettiche, ritornino. Le carceri, i centri migranti, le strutture per anziani sono ancora attive come risposte precostituite, semplicistiche, quasi automatiche, apparentemente rassicuranti ma di fatto inquietanti, fortemente disfunzionali e costose. Cresce il disagio nelle carceri, e si chiede una maggiore sanitarizzazione e psichiatrizzazione delle persone private della libertà piuttosto che rivedere le politiche giustizialiste e le condizione della detenzione a favorire il futuro rientro nella società. Ciò è fonte di sofferenze, sprechi di risorse. Le Residenze per Anziani dopo la strage del Covid, nonostante i propositi di riforma sono ancora lì senza alcun progetto organico di trasformazione. E vi è il rischio che siano la risposta prevalente alla cronicità.
La forza dell’istituzione è anche il suo automantenimento e ciò avviene più facilmente se ritornano ad esservi contesti chiusi, impermeabili alla partecipazione, dove la sofferenza è fatto privato sottratto allo sguardo pubblico. Così si possono affermare violenze, disinteresse e abbandono umano, politico ed etico, nonostante la Costituzione e le leggi parlino di diritti e di inclusione, nonché della informazione e del potere di denuncia e di trasformazione delle immagini. Oltre a Leros quanti altri luoghi?
Eppure, nonostante tutti i limiti l’Italia ha chiuso OP e OPG, reso la scuola di tutti per tutti. Molto resta da fare per la vita indipendente di disabili e anziani, per una diversa accoglienza degli stranieri e dare un altro senso alla pena detentiva. Ma pur con questi problemi, non sottovaluterei il valore di quanto abbiamo realizzato e la forza del welfare ancora in campo che essere universale e fronteggiare i rischi della solitudine e dell’isolamento abbandonico, delle vite di scarto e al contempo prevenire la segregazione dei devianti e dei disturbanti.
Colorno, Parma[1]
Il giudizio sul periodo di Basaglia a Colorno è variegato: Parma, un’occasione mancata (Colucci, 2001), un crocevia (Gallio, 2009). Secondo Giacanelli (2012) è stata “un unicum” e condivido con Slavich che ancora si tratti di “un anello mancante” tra l’esperienza di Gorizia e quella di Trieste. Un periodo di transizione che ha aspetti importanti per le fasi successive.
A Parma si dimostra “che si può fare” e andare oltre l’esperienza delle Comunità Terapeutiche fatta a Gorizia. Il sapere pratico unisce due personalità forti, Basaglia e Tommasini, che hanno partecipato alla lotta antifascista e conosciuto il carcere. Li accomuna la volontà di chiudere il manicomio, di portare avanti un processo di liberazione, umanizzazione e diffusione una nuova cultura.
E’ l’amministrazione provinciale di Parma che nel 1967, un anno prima de “L’Istituzione Negata”, promuove la pubblicazione del testo “Che cos’è la psichiatria?” dando un rilievo pubblico e politico all’azione di Basaglia. Un’azione che dimostra coraggio e la consapevolezza che la sfida vada vinta sul terreno culturale, del sapere critico mediante il dialogo, le assemblee, il dibattito. E’ questo incontro con i cittadini chiamati a partecipare, a collaborare, che crea fiducia, speranza e permette di superare paure, stigmi e genera ottimismo verso il futuro.
La spinta alla partecipazione di tanti nuovi soggetti (studenti, operai, intellettuali, artisti ecc.) offre nuove risorse e chiavi di lettura a sostegno di un processo di cambiamento che, da sola, la psichiatria non può attuare. Basaglia esprime la consapevolezza che il potere, anche quello psichiatrico (facile a deformarsi a sostegno dell’autorità) deve essere temperato e, al tempo stesso, anche il cambiamento che si può realizzare attraverso le modificazioni delle pratiche psichiatriche e sociali ha, in se stesso, indubbie limitazioni in quanto ogni nuova acquisizione apre nuove contraddizioni e bisogni.
Questo accade ancor di più se la pratica psichiatrica si colloca nel sociale e non vive in uno statuto “speciale” ma nelle norme di tutti. Non più un mondo a parte, quello del manicomio, ma nel contesto sociale, la psichiatria trova senso (in particolare nel welfare state che contribuisce a determinare), possibilità e limiti. Questo all’interno di un comune processo di emancipazione e di riscatto degli studenti, degli operai, delle donne e dei soggetti più deboli. Diversi soggetti, compresi tanti operatori, sono uniti nell’idea di un cambiamento necessario e inderogabile. Non tanto come opzione tecnica ma come approccio rispettoso della persona, la cui malattia/disturbo/condizione viene considerata secondaria, messa tra parentesi, perché prima vengono la conquista della libertà e dei diritti (dal vestiario, ad un minimo di denaro, alla libertà di uscire). Un volontarismo etico prima che politico e/o tecnico.
Nel 1970, quando, circa cinque anni dopo i primi contatti, Basaglia arriva a Parma da Gorizia, dove aveva prodotto, sul modello inglese, la progressiva trasformazione del manicomio in Comunità terapeutica trova una realtà in fermento ed evoluzione: nel 1969 l’ospedale psichiatrico di Colorno era stato occupato, la città era stata fortemente coinvolta con accese discussioni, erano iniziate le dimissioni dei pazienti in appartamenti che in pochi anni diverranno ben 150, i primi laboratori esterni, le Fattorie di Vigheffio e Castell’Aicardi.
Il coinvolgimento degli operatori e l’idea di una trasformazione in comunità dell’ospedale di Colorno promossi da Basaglia avvenivano in un contesto diverso da quello di Gorizia e la stessa azione innovativa interna all’OP, come emerge dai verbali pubblicati da Aut Aut (2009) apriva contraddizioni e risultava ben più difficile da sviluppare.
Tuttavia Parma indica una via per chiudere il manicomio: rappresentarlo, aprirlo, promuovere laboratori esterni, favorire i rientri in famiglia, alloggi e piccole comunità sensibilizzando i cittadini (gli incontri nei quartieri, circoli) ai quali si chiedeva accoglienza e solidarietà.
Franca Ongaro Basaglia nel libro “Manicomio Perché?” (1982) scrive dei tanti cambiamenti avvenuti a Parma e riferendosi in particolare della Fattoria di Vigheffio dice: “Un grande progetto, una grande intelligenza e una grande libertà, che non si sono fatte divorare dalle pastoie della burocrazia amministrativa e dalla logica della divisione delle competenze, hanno unificato la città in un’impresa in cui tutti possono riconoscersi: la fattoria non è più del Comune di Parma, ma dei suoi cittadini.”
Come già detto la “frenesia della pratica” di Tommasini non si limita al manicomio ma si estende ai disabili, al superamento delle classi differenziali, dei brefotrofi e nella filosofia della creazione di servizi che siano realmente dei cittadini che si attivano e si mobilitano sta il contributo dato da Parma alla realizzazione di quel processo di liberazione che si allarga fino a coinvolgere tutte le istituzioni totali (Rossi, 2006).
In questo quadro il periodo di Basaglia a Colorno è significativo per diverse ragioni:
- a Colorno si forma un gruppo che poi realizzerà con Basaglia il cambiamento a Trieste e ne continuerà l’opera per i successivi 40 anni: Rotelli, Dell’Acqua, Giovanna Del Giudice;
- a Gorizia e Colorno si formeranno diversi psichiatri che poi realizzeranno la chiusura di manicomi in diverse città di Italia;
- a Colorno, Basaglia sembra maturare la convinzione che “si può fare” grazie all’azione dirompente di Tommasini, che sposta l’attenzione all’esterno del manicomio, nella comunità, sul tornare a casa. Un tema questo molto caro a Tommasini tanto da denominare, molti anni dopo nel 1999, “Itaca”, un progetto di trasformazione della Fattoria di Vigheffio. Ancora pur tra tutte le difficoltà del quotidiano per rispondere ai bisogni, si consolida la speranza, l’ottimismo verso il futuro. Anche questo un argomento di Mario Tommasini, che chiamerà “Esperidi” il suo progetto non realizzato di superamento delle case di riposo per anziani. Certo a creare speranza influisce il sessantotto con i cambiamenti sociali che porteranno alla stagione delle riforme. Ma come sappiamo il cammino sarà ancora lungo e travagliato e per giungere a superare il c.d. “residuo manicomiale” serviranno ancora oltre venti anni (ufficialmente 1999).
- a Colorno matura il disincanto di Basaglia rispetto alla politica anche di sinistra: in un periodo caratterizzato da ideologie e rigidità (i conflitti con il PCI, l’ipotesi della direzione di Basaglia a Bologna non valutata positivamente dagli esponenti del partito…)., i piccoli dissapori gestionali per spese telefoniche ed al. con gli amministratori di Parma…;
- a Colorno segna la fine delle aspettative universitarie: Basaglia pur avendo avuto l’insegnamento di Igiene mentale all’Università di Parma (non va dimenticato che il prof. Visintini, docente di clinica della malattie nervose e mentali, aveva collaborato attivamente con Tommasini) non ottenne, come voleva, un nuovo reparto a direzione universitaria Colorno. Su questo Tommasini in Aut Aut (2009) dirà “mi sembrava assurdo dare trenta o quaranta posti letto alla clinica universitaria; se la nostra intenzione era vuotare il manicomio l’università ci avrebbe fermato o reso la cosa più difficile” (pag. 41). Da oltre 400 anni la questione della formazione universitaria degli psichiatri, infermieri ed altri operatori è tuttora aperta.
- la situazione familiare: Basaglia lavorò a Parma stando sempre in albergo e quindi lontano dalla famiglia che era rimasta a Venezia. Sul rapporto tra vita professionale e privata vi è il bel libro di Alberta Basaglia (2014).
Nel periodo di Colorno due eventi tragici uno all’interno dell’OP (il suicidio di un degente di Colorno) e l’altro all’esterno (il processo per l’omicidio della moglie da parte di un paziente di Gorizia uscito in permesso avvenuto nel settembre 1968) scuotono fortemente Basaglia e Tommasini. Basaglia che dopo l’omicidio va fortemente in crisi tanto da pensare di abbandonare tutto, nel periodo di Colorno deve affrontare il processo. Una fase difficile anche per Tommasini oggetto di diverse opposizioni e critiche. Di fronte a questo Tommasini si attiva per accelerare le forme di cambiamento del manicomio. Le difficoltà e i dilemmi che fino ad allora si erano evidenziati (fra il potere del medico e quello del paziente, la soggettività del malato e l’oggettività dell’istituzione, il benessere e diritti della persona e le esigenze della società) vengono messi in crisi dall’emergere del dramma della sofferenza umana inesprimibile, del gesto che, nella disperata ricerca di senso, interroga ciascuno e la comunità nel suo complesso. Basaglia riflette sull’esperienza riformatrice operata nell’ospedale di Gorizia e con Franca Basaglia scrive “Il problema dell’incidente” (1968) che resta un prezioso punto di riferimento.
Volendo sinterizzare l’esperienza di Colorno si può dire che essa vede l’incontro di due approcci ma l’amalgama, per ragioni di carattere e orgoglio, secondo Slavich (2019 pag. 381) non riuscì. Da un lato Basaglia che parte da conoscenze fenomenologiche mette tra parentesi la malattia e pone l’attenzione sulla persona che prima ancora che malata è esclusa, emarginata, priva di reddito e quindi bisognosa di emancipazione. E’ una questione di classe, di una psichiatria dei poveri rispetto a quella dei ricchi. Queste posizioni lo avvicinano da una parte alle correnti rivoluzionarie e di liberazione e dall’altra, impropriamente, all’antipsichiatria. Infatti, Basaglia mai ha negato la malattia mentale: ha piuttosto riconosciuto i limiti della conoscenza (“non so cosa sia la malattia mentale e nessuno sa cosa sia” dirà nell’intervista a Zavoli) e nega che esista una “tecnica basagliana”. Quella della tecnica e dell’organizzazione dei servizi rimarrà per anni una questione aperta (dipartimenti “forti” o “deboli”?, Centri Salute Mentale sulle 24 ore…) anche a Parma. Resterà un tema come organizzare il nuovo, dare forma e senso alle esperienze e proiettarle nel futuro (Carpanese, 2021) inventando istituzioni nuove come scrive Rotelli (2015).
Dall’altro, Tommasini promuove un’azione politica che si alimenta di un movimentismo umanitario volto a costruire alleanze con i più diversi interlocutori, una capacità di coinvolgimento, motivazione al di là delle ideologie, dei partiti, delle posizioni religiose, delle stesse competenze tecniche (Giacanelli, 2012) ecc. che crea soluzioni, attiva risorse e disponibilità a risolvere i problemi delle singole persone che incontrava perché bisognava fare qualcosa! Una chiamata della comunità a muoversi, a non restare indifferente, a fare la propria parte, ciascuno come può e come sa (volontarismo etico) coinvolgendo in primis, gli stessi malati. L’idea di dare diritti e nuove opportunità, anche di fronte a sfide “impossibili” cercando di creare un contesto accogliente e capace, tutto insieme, di recuperare salute e benessere fa di Tommasini un pensatore moderno e per alcuni aspetti visionario.
Un amalgama che a Colorno in quel tempo non si è realizzata ma poi è riuscita: ne è la dimostrazione che “l’impossibile” è diventato “possibile” in tutto il nostro Paese, con storie e strade diverse e questo unisce in modo indelebile Basaglia, Rotelli e Tommasini come espressioni simboliche di un intero movimento, senza trionfalismi, di un’epopea.
Le istituzioni
Il testo sulle istituzioni totali (Goffman, 1961) è stato importante per la deistituzionalizzazione. La lotta antiistituzionale si è confrontata con i rischi della trans-istituzionalizzazione o di creare dei vuoti.
“Ieri le istituzioni dell’esclusione erano potenti, disciplinate, legittimate. La pratica critica ne disvelava l’oppressione violenta e su questo si formò una generazione di operatori. Con Tommasini, Colorno divenne scuola di libertà per studenti, intellettuali, uomini e donne di ogni classe sociale” (Rotelli, 2017).
Un punto fondamentale per avere istituzioni partecipate, riformate in modo democratico, dialettico. Questo apre la questione del potere delle istituzioni: il manicomio aveva rigide gerarchie alle quali era attribuito anche il compito di tutelare e custodire il malato privato di tutti i diritti. Una situazione che come ricorda Piccione (2013) è in contrasto con la Costituzione la quale prevede una serie di norme volte a limitare il potere delle istituzioni, a tutelare le minoranze e i diritti delle persone. Un monito molto attuale che viene dalla lotta al nazismo e al fascismo troppo spesso dimenticata, a fronte di nuove, recenti e gravi forme di violenza, discriminazione e razzismo, di intolleranza del conflitto e del dissenso.
La lotta antiistituzionale accomuna Basaglia, Tommasini e Rotelli. Quest’ultimo nel corso della sua esperienza vedrà la necessità attraversare le istituzioni e di inventarne di nuove: “Istituzioni per la deistituzionalizzazione che nulla hanno a che vedere con forme di deregulation”. (2021 pag. 53) Cioè per realizzare le Microaree, la città che cura, fare della casa il primo luogo di cura occorre una infrastruttura, un’organizzazione che sia in grado di promuovere i diritti e stare accanto alle persone in un rinnovato, praticato e onorato (anche con il pagamento delle tasse) patto sociale.
La legge 180/1978 realizza i principi contenuti nella Costituzione della Repubblica: la salute come diritto della persona e al tempo stesso interesse della collettività che si invera grazie al servizio sanitario, definito da Rosy Bindi, la più grande opera pubblica del nostro Paese.
Servono istituzioni in grado di promuovere la libertà, volontarietà e il rispetto dei diritti, essenziali per la cura e l’inclusione della persona in una visione che sollecita lo sviluppo di una società solidale e inclusiva delle diversità a partire non tanto dalla malattia mentale, considerata essa stessa come enigmatica contraddizione, ma dalla persona del malato, specie da quello povero, solo e indifeso che proprio in relazione a questo è destinato a soffrire di più. Ne discende un mandato, al tempo stesso civile e giuridico, per rimuovere gli ostacoli sociali ed economici alla realizzazione della persona e a promuovere equità e giustizia. Questo appare palesemente in contrasto con la visione individualista che si è andata affermando negli ultimi trent’anni.
Manicomi, scuole differenziali, brefotrofi sono stati chiusi mentre case per anziani, carcere sono ancora lì e ad essi si sono aggiunti i centri di accoglienza temporanea per stranieri. Sono davanti ai nostri occhi ma non suscitano “scandalo” e indignazione.
Pur in questo quadro, si è avuta la forza, la capacità e l’intelligenza di riuscire a chiudere anche gli OPG. Operazione che anche a Basaglia appariva molto difficile e che Rotelli ha sostenuto seppure con posizioni critiche ma costruttive. Un’operazione che a distanza di 10 anni mette in evidenza la crisi del carcere, delle politiche sociali giustizialiste che di fronte al loro fallimento rischiano di accentuare ulteriormente i tratti repressivi e illiberali attaccando tutte le riforme degli anni 70.
Il disegno istituzionale deve necessariamente fare i conti con la fase della globalizzazione, della rivoluzione informatica, la privatizzazione della sofferenza. Le istituzioni della presa in cura selettiva e dell’abbandono e indifferenza portano da un lato a rischi di neoistituzionalizzazione da un lato (nel 2022 in Italia vi sono 415mila posti residenziali) e dell’isolamento dall’altro. Si pone come indicato da Rotelli la necessità di inventare un Istituzione che possa organizzare Servizi di Comunità e Prossimità per sostenere l Progetto di Vita delle persone.
Il 1980 l’anno della morte di Basaglia è segnato dalla vittoria del neoliberismo (Reagan e poco prima Thatcher nel Regno Unito) e inizia l’attacco al sistema di welfare pubblico universale. In fondo quella linea, con tutte le varianti, continua ancora oggi mettendo a rischio le conquiste e diritti.
Nel 1980 si ha anche la pubblicazione del DSM III (in Italia nel 1983) un manuale diagnostico statistico “ateoretico”, neokraepeliniano, che rende secondaria in psichiatria la psicopatologia, la relazione terapeutica e l’attenzione dell’assetto istituzionale e sociale. Un’operazione funzionale all’affermarsi di una psichiatria “globalizzata”, categoriale, semplificata, neopositivista non interessata alla soggettivazione quanto ad oggettivare sintomi o cluster da trattare farmacologicamente. Una linea distante dall’approccio olistico, del One Health, che prevede di affrontare i determinanti sociali della salute mediante il coinvolgimento attivo della società civile per non lasciare soli pazienti e operatori, non più in manicomio ma in un desolato e povero territorio. Pazienti che non sono più quelli di una volta. La loro immagine è cambiata: non più gli oppressi da liberare, reduci da risarcire ma persone spesso sensibili, invisibili, talora emarginate ma più frequentemente sofferenti in modo inapparente, nascosto o confuso nell’anonimato, di cui prendersi cura insieme tenendo conto del loro punto di vista sul percorso terapeutico e soprattutto delle loro scelte di vita.
Per concludere.
Con soddisfazione si può dire che, pur con tutti i limiti e le possibilità di ulteriore miglioramento, che i percorsi tracciati da Basaglia, Rotelli e Tommasini hanno trovato realizzazione: si è realizzata la chiusura dei manicomi e degli OPG. Sono conquiste che vanno difese a fronte di una situazione critica, di definanziamento ma soprattutto di perdita di spinta culturale, ideale e valoriale necessaria per sostenere il welfare pubblico essenziale per la salute mentale. La psichiatria può essere variamente declinata ma la nostra legge presuppone il servizio sanitario nazionale ed una comunità inclusiva. In questo quadro bisogni e risorse co-costruite possono portare ad un evoluzione dell’organizzazione e delle pratiche operative (per intensità di cura, orientate alla prevenzione, guarigione e inclusione sociale) per sistemi integrati di cura e di comunità (garante dei diritti/doveri di tutti, anche dei malati mentali) partecipati da utenti, familiari e cittadini. Un modo per ridare speranza e futuro alle persone, specie ai giovani: scuola, lavoro e affrontare la questione dell’assistenza ai bambini e adolescenti senza “psichiatrizzare la scuola”. Dobbiamo evitare che i valori della legge 180 diventino minoritari, non solo in psichiatria, ma nella società.
Il percorso di Rotelli da Castiglione delle Stiviere a Trieste, passando per Colorno e Caserta, porta idealmente dall’OPG all’istituzione inventata e alla città che cura. Un orizzonte utopico che deve registrare una crisi politica e culturale, una perdita di consenso che interroga. Perché la crisi del welfare pubblico universale, la crisi dei servizi di salute mentale di Trieste? La delusione per il venire meno dei diritti ridotti ad opportunità, l’abbandono dei giovani e delle fasce deboli, la Costituzione come riferimento vuoto, la globalizzazione e la rivoluzione informatica? Siamo ancore nella fase neoliberista iniziata nel 1980 per la quale la società non esiste ma siamo solo individui chiamati a competere. Ed è su questo che le parole di Pasolini sono illuminanti: “nulla si pone scandalosamente in rapporto dialettico con il liberalismo” (in Novello, 2023).
E’ su questo terreno sono mancati il conflitto radicale, la capacità di custodire tradizione, identità, memoria del molteplice, cultura dei diritti. Di fronte all’aumento delle diseguaglianze e delle povertà occorre un’analisi e una cornice di senso comune, nel momento in cui è a rischio l’umanità, la sua dignità e persino la vita del pianeta. Occorre sognare e creare utopie.
Quindi, alla domanda “Che cos’è la psichiatria?” si aggiungono altri quesiti: Quale patto sociale? Quale bene comune? Quale futuro per l’utopia realistica di Franco Rotelli e Mario Tommasini?
| modificato: | mercoledì 21 febbraio 2024 |
|---|